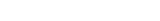In viaggio per dove?
Viaggiare per noi è diventato normale. L’autore Charles Lewinsky si domanda: lo scopo del viaggio è veramente raggiungere una meta lontana?
Se prendiamo la letteratura mondiale come rappresentazione della realtà ed esaminiamo le classiche storie di mobilità, allora lo scopo dei viaggi che vi sono descritti è sempre solo una meta lontana. Almeno apparentemente. Infatti, a un’osservazione più attenta risulta esattamente il contrario: i protagonisti si avventurano in Paesi ignoti solo per poter poi ritornare a casa. I grandi poeti dell’antichità lo sapevano già: Omero fa vivere a Ulisse le sue avventure in tutto il mondo allora conosciuto per poi farlo ritornare – dopo dieci movimentati anni – dalla moglie Penelope nella sua Itaca. E anche Giasone e i suoi Argonauti hanno intrapreso la loro spedizione alla ricerca del vello d’oro solo per poter portare a casa i loro trofei dopo innumerevoli gesta eroiche. Se saltiamo un paio di millenni, vediamo che non è cambiato nulla: anche Gulliver di Jonathan Swift e Robinson di Daniel Defoe visitano le regioni più remote del mondo solo per poi alla fine riportarne i racconti nella vecchia patria. Perfino la letteratura per l’infanzia conferma questo schema: Heidi è finalmente felice solo quando può ritornare dal Vecchio dell’Alpe, e anche Pippi Calzelunghe ritorna dall’isola di Taka Tuka all’amata Villa Villacolle.
Alla base di tutte queste storie – se ne potrebbero elencare centinaia di altre – c’è un messaggio: la meta ultima di ogni viaggio è il ritorno alla partenza. Per dirla in altre parole:
Per poter godere dei cambiamenti e delle emozioni della mobilità abbiamo bisogno di sapere che possiamo porvi termine in qualsiasi momento, se lo vogliamo. Finché non dimentichiamo da dove veniamo e abbiamo la certezza interiore che la via del ritorno non ci è preclusa per sempre, siamo liberi di scoprire il mondo.
Quando ci viene tolta questa libertà – anche se l’impossibilità di tornare al punto di partenza del nostro viaggio può essere solo immaginaria – veniamo attaccati dal «morbus helveticus», come veniva chiamato nel XVIII secolo. In altre parole: sentiamo nostalgia di casa. I mercenari della Confederazione all’estero ne erano spesso afflitti, tanto da disertare quando sentivano il canto «Ranz des Vaches», anche se si trovavano non molto distanti dall’amata patria. Già l’Alsazia poteva essere troppo lontana dal Paese d’origine, così come descrive questo canto popolare del disertore malato di nostalgia: «A Strasburgo, nella trincea, là è iniziato il mio dolore.»
Il fatto che si possa essere colpiti dalla nostalgia come da un virus non significa, però, che la mobilità, cioè lo stato di essere in viaggio o da qualche altra parte, abbia una valenza negativa. Se la voglia di avventure e la gioia della scoperta non fossero saldamente ancorati nei nostri geni, allora l’umanità non sarebbe mai uscita dalla steppa africana, nessuno cercherebbe di dare alla propria vita nuovi contenuti in un altro Paese, e i voli per le Maldive non sarebbero così richiesti. Ma abbiamo anche la certezza che c’è sempre un altro aereo che ci riporta in tutta fretta verso la Svizzera, in caso di emergenza.
E c’è un altro motivo per cui la nostalgia di casa propria non è più un morbo virulento, ma al massimo un innocuo raffreddore dell’anima. Le diverse parti del mondo stanno diventando sempre più simili. Naturalmente gli australiani saranno sempre più ospitali degli svizzeri, gli israeliani più scortesi e gli italiani più caotici. Ma ormai in tutto il mondo troviamo lo stesso Starbucks, che offre lo stesso caffellatte grande con latte di soia e vaniglia, e quando passeggiamo in qualsiasi via dello shopping o centro commerciale vediamo sempre gli stessi negozi, disposti solo in una sequenza diversa. Abbiamo la sensazione di essere incredibilmente mobili, ma spesso abbiamo solo fatto in modo che l’altrove abbia lo stesso aspetto di casa nostra.
Se Circe avesse cantato gli stessi canti riproposti anche dalla hit-parade di Itaca, Ulisse non avrebbe dovuto tapparsi le orecchie, ma avrebbe potuto gettare l’ancora e unirsi al coro. Gulliver sarebbe rimasto dai lillipuziani, se nel supermercato lì vicino avesse trovato il suo muesli preferito per la colazione, anche se le confezioni minuscole sarebbero state una seccatura. E Pippi Calzelunghe sarebbe ancora sull’isola Taka Tuka, se la tv locale avesse trasmesso le serie televisive che amava guardare quando era alla Villa Villacolle.
Quanto più naturale diventa per noi il viaggiare in tutto il mondo, tanto più difficile è fare della mobilità una vera esperienza. Perché se questo termine deve avere un senso, allora non può definire semplicemente un mutamento spaziale, ma deve comprendere anche la disponibilità a entrare in rapporto con un ambiente diverso. Se l’ambiente è uguale ovunque, non abbiamo più alcun motivo di tornare a casa. Un ambiente familiare che troviamo dappertutto prima o poi perde le sue caratteristiche di unicità.